Conosci i principi di gioco dei tre allenatori italiani "Campioni del mondo"?
- Alessandro Moppi

- 23 set 2025
- Tempo di lettura: 19 min
Aggiornamento: 28 set 2025
Nel precedente articolo abbiamo parlato di alcune curiosità riguardanti i Campionati Mondiali, in questa guida analizzeremo tattiche, principi e sviluppi di gioco delle 4 nazionali italiane diventate Campioni del Mondo.
L’analisi partirà dalla più lontana in ordine di tempo, cioè con la nazionale di Vittorio Pozzo, che negli anni ‘30 era sicuramente la nazionale più forte del mondo e che dal 1934 al 1938 vinse i due titoli mondiali e l’Olimpiade del 1936.
L’Italia 1934
La nazionale campione del mondo nel 1934 giocava con uno stile molto diverso da quello moderno, ma estremamente efficace per l’epoca. La squadra vinse il torneo disputato in casa, diventando la prima nazionale europea a conquistare il titolo mondiale. Ecco una panoramica del sistema, stile di gioco e giocatori chiave.
Sistema
Il "Metodo" era un'evoluzione della “Piramide” o del sistema “WM” inglese, molto in voga in quegli anni. Si trattava di un sistema 2-3-2-3 o WW, dove:
2 difensori centrali (nel sistema erano 3) che avevano due compiti diversi: uno marcava il centravanti avversario, l’altro era una sorta di libero che doveva intervenire su qualsiasi pallone nel caso la difesa fosse in difficoltà.
3 centrocampisti (detti "mediani" o "terzini centrali"): i due laterali agivano da terzini fluidi coprendo le fasce e il centrocampista centrale (centromediano metodista) doveva impostare e proteggere la difesa.
2 mezzali che avevano licenza di agire tra centrocampo e attacco
3 attaccanti (2 ali e un centravanti) che completavano il reparto offensivo
La terza linea, quindi, era formata da cinque giocatori: le due mezzali avevano un compito più difensivo perché dovevano coprire lo spazio lasciato dai due mediani laterali che andavano a marcare le ali avversarie e in questo modo si creava una maggiore superiorità numerica a centrocampo favorendo una maggior copertura difensiva che permetteva contrattacchi più veloci ed efficaci.
Grazie a questo, le due ali avevano maggiore libertà di azione, assistendo il centravanti o mettendosi in proprio. L’unico compito del centravanti, ovviamente era quello di segnare.
Stile di gioco
Pozzo era noto per la sua abilità nel gestire tatticamente la squadra. Puntava sulla solidità difensiva, ma anche sulla versatilità e intelligenza dei suoi giocatori.
L'Italia aveva una difesa solida, con i due difensori (chiamati terzini) forti e ben complementari fra loro, con i mediani laterali che spesso si sovrapponevano in fase offensiva e un metodista che agiva da "metronomo" del gioco.
Le mezzali, dotate anche di buone doti d’inserimento, riuscivano ad aiutare la squadra nelle due fasi.
Gli attaccanti erano veloci e abili nel dribbling, con un attaccante centrale di riferimento e ali capaci di creare occasioni da gol.
La squadra era molto attenta a non scoprirsi, i giocatori addetti al reparto difensivo non erano mai meno di cinque, con un pressing organizzato e un ripiegamento difensivo efficace.
Lasciava spesso il pallino del gioco agli avversari, chiudendosi bene in difesa, per poi, una volta recuperata palla, verticalizzare subito con lanci lunghi e veloci ripartenze.
Una volta che la palla era in possesso delle ali un’azione molta ricercata era, oltre al dribbling, anche il cross per il centravanti.
Era un sistema molto disciplinato e fisico, ma lasciava spazio anche alla creatività di alcuni giocatori offensivi.
La diffenza fra il “Metodo” e il “Sistema” è la maggior distanza fra i reparti difensivo e offensivo e quindi la necessità di ricorrere ai lanci lunghi rispetto al gioco più corto e vicino del “Sistema”.
Con il “Metodo” nasce quindi quello che oggi fino a qualche anno fa chiamavamo contropiede e oggi definiamo ripartenze o meglio “transizioni offensive”.
In sintesi, il "metodo" Pozzo era una tattica pragmatica e funzionale, che sfruttava le caratteristiche dei giocatori a disposizione per ottenere il massimo risultato.

(La formazione della finale del 10/06/1934 a Roma contro la Cecoslovacchia)
Giocatori chiave
In quella nazionale c’erano alcuni giocatori che spiccavano sugli altri per carisma e qualità tecniche:
Gianpiero Combi: portiere e capitano, grande carisma e sicurezza tra i pali (lasciò la nazionale a fine torneo)
Luis Monti: argentino naturalizzato italiano, mediano fortissimo fisicamente e tatticamente. Curiosità: non era la prima finale mondiale per lui perché aveva già giocato (e perso) la finale mondiale del 1930 con l’Argentina.
Giuseppe Meazza: era il fuoriclasse della squadra. Centrocampista offensivo o attaccante, dotato di tecnica, dribbling e senso del gol. Meazza era già un campione consacrato. Pozzo gli affidò il compito di legare le due fasi e prendere in mano la squadra (più avanti ne parleremo più nello specifico).
Angelo Schiavio: centravanti e autore del gol decisivo in finale contro la Cecoslovacchia che fu anche l’ultimo della sua carriera perché si ritirò dopo quella partita a soli 29 anni.


(le due immagini sopra, la prima reale e l’altra fumettata, mostrano il gol decisivo di Schiavio nella finale contro la Cecoslovacchia)
L’Italia 1938
La seconda Italia campione del Mondo, sempre sotto la guida del CT Pozzo, aveva sempre come riferimento il “metodo”, cioè il 2-3-2-3, ma in quei 4 anni erano cambiati gli interpreti.
E’ considerata una delle squadre più forti della storia del calcio italiano. Il suo stile di gioco rifletteva perfettamente l’epoca: fisico, tattico, disciplinato, ma anche con sprazzi di grande tecnica individuale.

(La formazione della finale contro l’Ungheria disputata a Parigi il 19/06/1938)
Stile di gioco
La difesa solida e organizzata, i due terzini, Foni e Rava, erano rocciosi e molto disciplinati tatticamente. La linea a tre di centrocampo fungeva da filtro molto efficace. Il centrocampo era operaio ma al contempo intelligente; giocatori come Andreolo, oriundo di origini uruguayane, erano fondamentali per spezzare il gioco avversario e rilanciare l'azione. Si privilegiava l’ordine tattico alla fantasia.
Il gioco era verticale e rapido; nonostante l’apparente staticità, l’Italia sapeva attaccare con grande efficacia, soprattutto in contropiede. La squadra aveva forti individualità in attacco:
- Meazza: diventato capitano e uno dei due superstiti, insieme a Ferrari, del Mondiale del 1934, era il regista offensivo, una mezzala moderna con tecnica, intelligenza e leadership.
- Colaussi e Biavati: ali moderne, forti nell’1v1 e che tagliavano spesso dentro al campo
- Piola: centravanti potente, cinico e prolifico
Appendice
Giuseppe Meazza: “Averlo in squadra significava partire dall'1-0”.
Così diceva Vittorio Pozzo del suo numero 10.
Considerato da alcuni esperti il più grande calciatore italiano di tutti i tempi, nonché tra i migliori in assoluto, occupa la 37ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer e la 21ª posizione nell'omonima lista stilata dall'IFFHS.
Il “Balilla” era un eccellente tiratore, rapido nei movimenti e avvezzo a giocate acrobatiche, era dotato di notevoli qualità tecniche, che sfociavano in una spiccata propensione a eludere il diretto avversario con delle finte.
Il suo tipico modo di andare in gol, cioè saltando il portiere, fu nominato “gol alla Meazza o a invito”.
Con la nazionale giocò 43 partite segnando 28 gol; nei club giocò principalmente con l’Inter e poi col Milan; a lui è intitolato dal 1980 lo stadio di Milano.
Silvio Piola: Annoverato tra i più grandi centravanti della storia del calcio italiano, ha legato la sua carriera principalmente a tre maglie, quelle di Pro Vercelli, Novara e Lazio.
Detiene diversi primati nei massimi campionati nazionali: pur avendo saltato una stagione a causa della seconda guerra mondiale, ne è il miglior marcatore con 290 reti (274 in Serie A e 16 in Divisione Nazionale 1945-1946); dal 1933, con 6 reti, detiene il record di marcature in una singola gara del massimo campionato italiano, eguagliato da Omar Sívori nel 1961.
In nazionale ha giocato 34 partite segnando 30 gol.


(nelle immagini, reale e fumettata, il gol del 4-2 di Piola che mise il sigillo sulla Coppa Rimet del 1938 contro l’Ungheria)
Vittorio Pozzo: soprannominato il “Tenente” per il suo passato militare, è stato il primo CT della nazionale e l’unico allenatore nella storia del calcio a salire per due volte sul gradino più alto della Coppa del Mondo, guidando l’Italia a due vittorie nel 1934 e nel 1938.
Possiamo considerare Pozzo un innovatore dell’epoca; oltre ad aver inventato il sistema 2-3-2-3 e il contropiede, fu anche il primo ad introdurre i “ritiri” per le squadre e, si dice, pretendeva che i giocatori, prima di entrare in campo, baciassero la maglia e intonassero un inno patriottico.
Nel 1938 fu insignito con la “Stella al merito sportivo”. Dal 24 novembre 1935 al 20 luglio 1939 inanellò una serie di 30 risultati utili consecutivi, record battuto solo da Lippi, anche se in 2 incarichi diversi, e dalla nazionale di Mancini.
L’Italia 1982
La nazionale italiana 1982 vinse il mondiale ma in partenza sicuramente non era una delle favorite. Gli azzurri giocavano con uno stile solido, pragmatico e compatto, basato su una difesa molto organizzata, un centrocampo di sacrificio e un attacco rapido ed efficace.
Struttura tattica
L’Italia 1982 applicava un “catenaccio moderno”, quella che si chiamava “zona mista”. La squadra era allenata da Enzo Bearzot, e la squadra partiva inizialmente con l’idea di una difesa a 4 con il libero che giocava davanti al portiere, l’altro difensore, definito all’epoca lo “stopper”, che marcava, e uno dei due laterali difensivi, spesso il destro che era il secondo marcatore.
L’altro esterno difensivo, in genere il sinistro, come nel caso degli azzurri, giocava a tutta fascia e fu introdotto il termine di “fluidificante”.
Il centrocampo era composto da un mediano, un regista e una mezzala.
Gli attaccanti invece erano in genere un’ala destra, un centravanti e a sinistra giocava un attaccante che spesso si accentrava per lasciare spazio al fluidificante; alla fine il sistema, da un 1-4-3-3 teorico, diventava una sorta di 1-3-5-2.
Andiamo adesso ad analizzare nel dettaglio i ruoli e gli interpreti dei nostri azzurri:
Dino Zoff: il portiere, veterano e capitano della squadra, esempio di leadership e affidabilità
Gaetano Scirea: libero straordinario nel suo ruolo, dotato di grande lettura situazionale sia in caso di elusione della marcatura dei suoi compagni sia in caso di raddoppio.
Fulvio Collovati: lo “stopper” che aveva il compito di marcare a uomo uno degli attaccanti avversari
Claudio Gentile: in teoria partiva come esterno difensivo di destra ma soprattutto nelle partite più importanti aveva il compito di marcare i giocatori più talentuosi della squadra avversaria, Maradona che fu letteralmente annullato, Zico e Littbarsky, solo per citare i più importanti di quel mondiale.
Antonio Cabrini: il moderno esterno fluidificante che giocava a tutta fascia ed amava mettere cross taglienti e pericolosi per le difese avversarie come in occasione del primo gol di Rossi col Brasile; segnò anche qualche gol in quella edizione, ma sbagliò il rigore in finale che per fortuna non pregiudicò il risultato.
Giancarlo Antognoni: regista e mente della squadra, un vero numero 10, anche se giocava col 9 nell’occasione; fu uno dei migliori giocatori del torneo
Gabriele Oriali: era il classico mediano, come ci ricorda anche una canzone di Ligabue a lui dedicata
Marco Tardelli: mezzala a tutto campo, quello che oggi chiameremmo centrocampista box-to-box
Bruno Conti: esterno offensivo destro di attacco ma giocava comunque a tutta fascia visto che in fase difensiva doveva coprire lo spazio lasciato da Gentile che era in marcatura a uomo. Aveva doti di rapidità, velocità e dribbling che gli permetteva di saltare spesso l’uomo, creare superiorità e mettere cross a rientrare (era mancino) per l’inserimento dei centrocampisti
Francesco Graziani: più attaccante che vero e proprio esterno, aveva il compito di partire da sinistra per poi accentrarsi per andare in aiuto al centravanti e lasciare spazio a Cabrini.
Paolo Rossi: opportunista e finalizzatore dell’area di rigore; fu lui a trascinare l’Italia al titolo con 6 gol nelle ultime tre partite diventando il capocannoniere del torneo, e che gli permise anche di vincere il Pallone d’Oro.

(struttura tattica dell’Italia ’82)
Stile di gioco
In fase di non possesso, Bearzot chiedeva ai suoi di chiudersi bene e di ricercare la compattezza, anche alla seconda punta, Graziani, veniva richiesto di rientrare sotto la linea della palla.
Gli azzurri si esaltavano quando recuperavano il pallone e ripartivano con contropiedi più o meno manovrati, grazie anche alle qualità polivalenti dei calciatori.
A)


(In queste prime 4 immagini vediamo la nazionale azzurra che rientrava tutta fino alla linea del centrocampo con tutti gli effettivi, per poi iniziare il pressing)
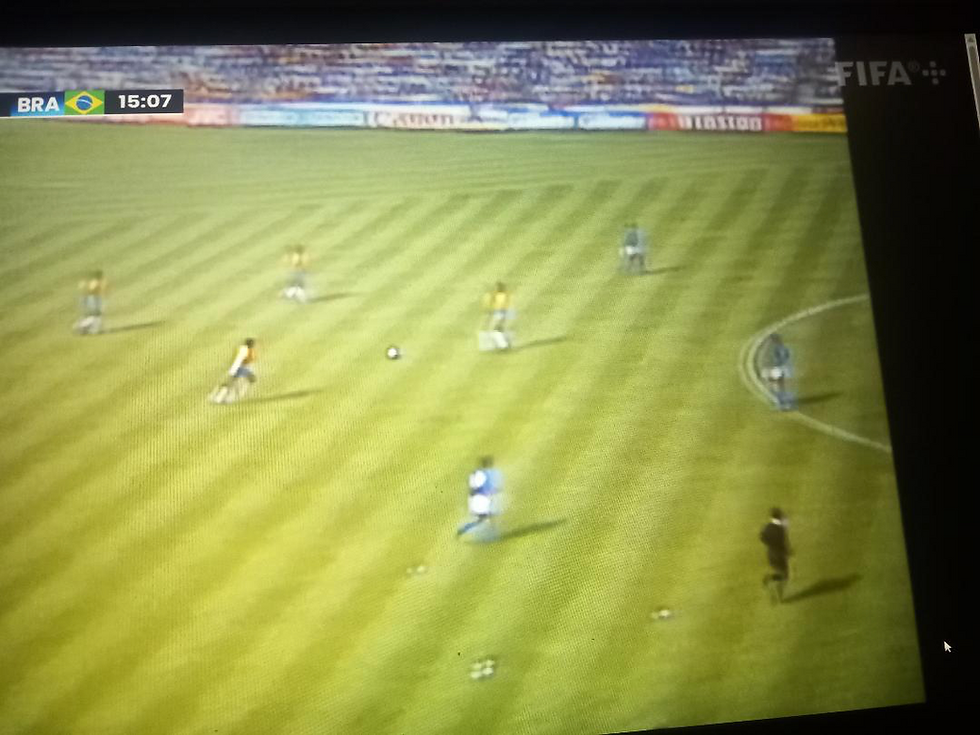

B)
Qua sotto invece la sequenza della ripartenza con scambi veloci fra gli azzurri che portò al gol di Tardelli contro l’Argentina


In fase di possesso si ricercavano sempre con più o meno azioni manovrate, le verticalizzazioni e i lanci per Conti o i due attaccanti.
Questo principio è evidenziato nell’azione del secondo gol della finale, quello del famoso urlo di Tardelli che tutti conosciamo, in cui l’azione parte dal recupero palla di dell’attaccante, in quel caso Rossi, su Breitner, nella propria metà campo andando poi, con molti giocatori azzurri, ad invadere la metà campo avversaria e dopo un fraseggio nel terzo offensivo di destra, permetterà proprio a Tardelli di segnare con un tiro dal limite dell’area.
Molto ricercati erano anche, come spesso accade per le squadre che giocano con 5 centrocampisti, i cambi campo come fu in occasione del cross di Cabrini per il primo di gol di Rossi contro il Brasile.
Quando l’azione ripartiva da dietro, la palla passava quasi sempre da Scirea.
In finale con la Germania il tecnico friulano attuò un cambio tattico perché Antognoni infortunato fu sostituito da Giuseppe Bergomi, altro difensore, quindi, all’inizio si presentò con una sorta di 1-4-4-2 con Cabrini e Conti fare gli esterni di centrocampo e lo stesso Bergomi che copriva le spalle all’esterno sinistro; dopo pochi minuti di partita Alessandro Altobelli, centrocampista offensivo, sostituì Graziani anche lui infortunato.
Italia- Brasile: 3-2 (Quarto di finale)
Sicuramente la partita simbolo di quel mondiale.
I brasiliani erano i grandi favoriti del torneo e in quella partita avevano due risultati su tre, infatti nel gironcino a tre squadre della seconda fase, l’Argentina era stata battuta da entrambe, ma i brasiliani avevano una miglior differenza reti, quindi, a loro sarebbe bastato un pareggio per andare in semifinale.
Quella verdeoro, era, a detta di tutti, la squadra brasiliana più forte di sempre e la nazionale che abbia giocato il miglior calcio in assoluto; tra le loro fila c’erano giocatori quali Junior, Falcao, Zico, Cerezo e il capitano Socrates.
La partita evidenziò un confronto tra due stili di gioco diametralmente opposti: la solidità difensiva e la concretezza italiana contro la spettacolarità e il talento offensivo brasiliano.
Il Brasile, allenato da Telê Santana, si presentava con un modulo 1-4-2-2-2, caratterizzato da un gioco offensivo e spettacolare, con centrocampisti talentuosi.
L'obiettivo era quello di dominare il centrocampo e creare occasioni da gol, sfruttando la tecnica e l'estro dei suoi giocatori ricercando tagli e inserimenti.
L'Italia, guidata da Bearzot, giocava con un modulo 1-3-5-2, incentrato sulla solidità difensiva e il contropiede.
Punti chiave della partita
Solidità difensiva: La difesa azzurra marcò a uomo i giocatori chiave del Brasile, limitandone il potenziale offensivo.
Contropiede: L'Italia sfruttò al meglio le ripartenze, con Rossi abile nel finalizzare le azioni offensive.
Il Brasile, pur giocando bene, peccò di cinismo sotto porta e di qualche errore difensivo, mentre l'Italia dimostrò una grande organizzazione tattica e una notevole capacità di concretizzare le occasioni.
La partita fu una lezione di calcio, con l'Italia che seppe coniugare la sua tradizionale solidità difensiva con un attacco efficace, sfruttando al meglio le debolezze del Brasile.

(nell’immagine vediamo il blocco basso che attuava l’Italia, difendendosi con tutti gli effettivi; nb: putroppo per le immagini dell’epoca non si vedono gli altri due giocatori italiani che sono nella parte sinistra dell’area di rigore)
Appendice 2
Enzo Bearzot: soprannominato il “Vecio”, dopo un inizio di carriera come preparatore dei portieri e poi assistente di Nereo Rocco ed Edmondo Fabbri, allenò per 6 mesi il Prato in serie C.
In seguito, entrò nei quadri federali come allenatore dell’Under 23 e poi come assistente dei CT Valcareggi e Bernardini. Nel 1975 divenne CT della nazionale, prima insieme allo stesso Bernardini, poi dal 1977 come commissario unico.
Già nel 1978 si iniziarono a vedere i frutti del suo lavoro, con la nazionale azzurra che arrivò quarta al mondiale in Argentina, ma esprimendo il miglior calcio del torneo. Lasciò la nazionale dopo il mondiale messicano del 1986.
È il commissario tecnico più longevo, con ben 104 panchine.
L’Italia 2006
Purtroppo, son passati quasi 20 anni dal nostro ultimo successo mondiale, ma io personalmente ho ancora un ricordo vivo e bello di quella fantastica avventura. L’Italia calcistica, subito prima del mondiale, entrò nel vortice dello scandalo di Calciopoli, e Marcello Lippi fu bravo a isolare il gruppo e pensare solo al campo.
Analisi tattica
L’Italia di Lippi non aveva un sistema di gioco fisso, ma lo adattava in base ai giocatori in campo e agli avversari.
Il punto cardine era la difesa a 4, mentre centrocampo e attacco hanno subito variazioni durante tutta la competizione.
I sistemi usati sono stati 1-4-3-1-2, 1-4-3-2-1, 1-4-3-3 e 1-4-4-1 (1-4-2-3-1)
Il CT aveva molta scelta sia dal punto di vista della qualità che della varietà di caratteristiche: a parte il portiere, da cui non ci si poteva distogliere e che era Buffon, la linea difensiva si basava su centrali solidi e forti in marcatura quali:
Cannavaro: il capitano (ne parleremo a parte più avanti)
Nesta: giocò poco perché spesso infortunato
Materazzi: fu il sostituto di Nesta
Barzagli
sugli esterni c’erano dei giocatori che erano dei veri e propri fluidificanti che facevano bene la fase difensiva ma erano sempre molto pericolosi anche in fase offensiva:
Zambrotta a destra, e Grosso a sinistra, erano i titolari
Oddo era il loro sostituto naturale
Zaccardo, che dopo lo sfortunato autogol con gli USA fu messo un po’ in disparte.
Il centrocampo non poteva prescindere da Pirlo, il regista e genio della squadra, a cui venne affiancato un “recupera palloni” quale Gattuso o De Rossi, (De Rossi per l’espulsione con gli USA alla seconda partita fu squalificato 4 partite e rigiocò solo la finale); gli altri giocatori si alternavano:
Perrotta: avevano caratteristiche di incursore, ma poteva giocare anche da esterno
Barone: anch’egli con caratteristiche simili al compagno sopra, ma forse un po’ più regista
Camoranesi: esterno ma all’occorenza anche trequartista o mezzala, aveva buon dribbling, buona tecnica e buona capacità di inserimento.
Per quanto riguarda l’attacco non c’erano posti fissi, ma i giocatori furono ruotati:
Totti (rientrato a tempo di recordo dopo infortunio grave alla caviglia a febbraio) e Del Piero erano i fantasisti
Toni era l’ariete da area di rigore ma che non disdegnava giocare con i compagni
Gilardino e Iaquinta avevano più caratteristiche da contropiedisti e gioco in profondità
Inzaghi era il classico finalizzatore da area di rigore
Vedendo le caratteristiche dei vari reparti e dei giocatori capiamo perché non veniva utilizzato un sistema fisso.

(1-4-3-1-2 usato nelle prime due partite con Ghana e USA)

(1-4-3-2-1 impostato contro la Repubblica Ceca nell’ultima partita del girone)

(1-4-3-2-1 utilizzato contro l’Australia nell’ottavo di finale)

(l’1-4-2-3-1 o anche 1-4-4-1-1 usato nelle 3 restanti partite con Ucraina, Germania e Francia)
Abbiamo visto che i sistemi variavano sia da partita a partita che durante la partita stessa, possiamo aggiungere che nelle partite quelle decisive con avversari del calibro di Germania e Francia si è maggiormente cercato equilibrio inserendo più centrocampisti, anche se c’è da evidenziare che nei minuti finali dei supplementari della semifinale contro la Germania, in cui abbiamo sbloccato il risultato, la squadra aveva in campo 4 attaccanti, che riuscirono comunque a dare equilibrio.
L’Italia in quella edizione mostrò pochi punti deboli, ma molti punti di forza:
Una difesa forte e organizzata: la nazionale subì solo 2 reti, una su rigore e una su autogol; in rosa c’erano quattro centrali tutti forti in marcatura; la dove non arrivava la difesa, c’era Buffon, che con alcune ottime parate ha rimediato alle poche sbavature avute dalla difesa azzurra
Variazione dei sistemi di gioco, ma la base era la difesa a 4
Rotazione degli uomini, soprattutto centrocampo e attacco, per gestire bene le energie: gli unici che non entrarono mai in campo furono i 2 portieri di riserva Peruzzi e Amelia
Gioco sulle fasce: espresso soprattutto a sinistra con Grosso, cui, nascendo esterno alto, piaceva, appena possibile sfruttare la fascia sia palla piede o inserendosi e rendendosi quasi sempre pericoloso, l’esterno sinistro veniva lanciato sia da Pirlo o da dietro da Materazzi; anche Zambrotta, con meno frequenza, e più dotato in fase difensiva, non disdegnava sganciarsi e lanciarsi sulla fascia. Entrambi comunque erano bravi nel saltare l’uomo, a dialogare con i compagni, ad accentrarsi e andare alla conclusione o crossare. Rivedendo comunque quelle partite possiamo dire che il gioco offensivo quando manovrato, passava molto dalla fascia sinistra, anche favorito dal movimento degli attaccanti e del centrocampista, spesso Perrotta, che tendevano proprio ad accentrarsi e lasciare lo spazio per il movimento di Grosso.

(in questa sequenza vediamo il lancio di Totti per Grosso che dopo il controllo salta 2 uomini e viene atterrato in area)
Ripartenze veloci: da corner avversario, gli azzurri ripartivano sempre con molti uomini che andavano ad invadere velocemente la metà avversaria; anche nel caso di recupero palla durante il gioco, si cercava subito la verticalizzazione su una punta (gol al Ghana di Iaquinta, gol alla Repubblica Ceca di Inzaghi e il gol del 2-0 di Del Piero in semifinale contro la Germania)

(Nella sequenza il gol in ripartenza dopo recupero palla di Inzaghi contro la Repubblica Ceca)
Gol da palle inattive: 3 furono le reti messe a segno da palla inattiva, due di Materazzi (Repubblica Ceca e in finale contro la Francia), e una di Toni (nell’ottavo contro l’Ucraina), facilitati anche da battitori come Pirlo o Totti

(la sequenza del gol del pareggio di Materazzi contro la Francia)
Molti uomini in gol: la nazionale non ebbe un trascinatore come fu nell’82 con Pablito, ma dei 12 gol messi a segno dagli azzurri, solo Toni e Materazzi ne segnarono 2 a testa, gli altri, Iaquinta, Pirlo, Inzaghi, Totti, Del Piero, Gilardino, Zambrotta e Grosso ne segnarono uno ciascuno.
Possiamo aggiungere che la fase di costruzione su rimessa dal fondo del portiere era quasi completamente assente, spesso si cercava il lancio sulle punte e l’attacco della seconda palla, ma lo facevano molte se non quasi tutte le nazionali, non eravamo ancora nell’epoca della ricerca della costruzione dal basso che sarebbe stata introdotta qualche anno dopo.
Nelle fasi in cui si ricercava la costruzione dai difensori, con palla in gioco, il delegato era Materazzi, dotato di buona tecnica lo sviluppo avveniva tramite lancio o pochi fraseggi corti, protagonista qui era Pirlo, con l’obiettivo di arrivare prima possibile nel terzo offensivo tramite o verticalizzazioni improvvise con inserimento diretto dei centrocampisti, soprattutto Perrotta, o con palla sugli attaccanti per il gioco di sponda o verso l’esterno.
Italia – Germania 2-0 d.t.s (Semifinale)
Se per il Mundial’82 la partita chiave ed iconica era stata quella con i verdeoro, per il mondiale tedesco, fu sicuramente la semifinale contro i padroni di casa giocata al allora chiamato Westfalenstadion di Dortmund.
La Germania si schierava in contrapposizione alla formazione italiana vista precedentemente, più o meno allo stesso modo, con un 1-4-4-2/1-4-4-1-1.
Le due squadre giocarono a viso aperto, ribattendo colpo su colpo, con la i tedeschi che tenevano maggiormente il possesso e cercavano di aprire la difesa azzurra con le due punte e permettere ai centrocampisti centrali di inserirsi negli spazi.
Gattuso fu l’uomo che disegnato per coprire questi inserimenti oltre che a raddoppiare sulla fascia destra, a sinistra il delegato era Perrotta.
Anche i cross erano molto ricercati dai giocatori teutonici ma abbastanza ben controllati da tutta la linea azzurra. La compattezza della fase difensiva azzurra costrinse i tedeschi a provare con molte conclusioni da fuori.
Anche la presenza di Totti fu importante; in fase difensiva si abbassava ad aiutare il centrocampo, in fase offensiva, il suo muoversie venire incontro, apriva gli spazi per gli inserimenti di dei compagni.
Nei supplementari ci fu la svolta anche a livello tattico. Lippi che aveva già inserito Gilardino per Toni che gli permetteva una maggior profondità e velocità davanti, all’inizio dell’extratime inserirì Iaquinta, attaccante, al posto di Camoranesi, come esterno destro e probabilmente fu un segnale di coraggio oltre che una scelta tattica.
Questa mossa dette appunto coraggio all’Italia e costrinse i tedeschi a difendersi e affidarsi a lanci lunghi. Come già detto, l’Italia finirà la partita con in campo Totti, Iaquinta, Gilardino e Del Piero più Pirlo segno di fiducia e sacrificio da parte di tutti.
Possiamo anche dire che Lippi vinse la partita a livello tattico, avendo saputo gestire bene la prima parte e saputo cambiare strategia in corso, probabilmente anche con mosse inaspettate dalla parte della Germania, il cui allenatore, Klinsmann, non seppe cambiare spartito e inerzia della gara dopo la crescita della nostra nazionale.
Appendice 3.0
Fabio Cannavaro: capitano e leader della difesa, fu protagonista di un mondiale perfetto, in cui non sbagliò praticamente niente, fra anticipi, gioco aereo e scivolate. Ancora oggi tutti quelli che hanno visto quella partita ricordando le tre famose esclamazioni del telecronista “Cannavaro!, Cannavaro!, Cannavaro!” nei 3 interventi precedenti l’azione del gol del 2-0 di Del Piero contro la Germania. Tutto questo gli fu riconosciuto con l’investitura del Pallone d’oro.
Fabio Grosso: considerato il talismano, l’uomo dell’ultimo minuto: fu lui a procurarsi il rigore al 93’ contro l’Australia, fu lui a segnare il gol dell’1-0 al 119’ nella semifinale contro la Germania e, infine, fu lui, a tirare e segnare il rigore decisivo nella finale contro la Francia.
Marcello Lippi: Ha allenato la nazionale dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2010; a cavallo di queste due avventure, ha battuto il record di Pozzo, che era di 30, di 31 partite consecutive senza sconfitte, battuto poi da Mancini. Con la vittoria del Mondiale 2006 è diventato il primo allenatore a vincere le due massime competizioni internazioni per club (la Coppa Intercontinentale nel 1996 con la Juventus) e appunto per nazioni, primato adesso condiviso con lo spagnolo Del Bosque. Riconosciuto migliore allenatore dall'Associazione Italiana Calciatori (1997, 1998, 2003), dall'UEFA (1997-98), allenatore e CT dell'anno dall'International Federation of Football History & Statistics (1997, 1998, 2006); introdotto nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2011.
Nel 2013 Lippi diventò il primo allenatore al mondo ad avere vinto le massime competizioni internazionali organizzate da almeno due Confederazioni, dopo i trionfi in UEFA Champions League nel 1995-1996 (Juventus) e in AFC Champions League nel 2013 (Guangzhou Evergrande); un primato eguagliato da Luiz Felipe Scolari.
Similitudini fra Campioni del Mondo:
Le quattro nazionali italiane campioni del mondo presentano alcune interessanti similitudini, nonostante le evidenti differenze storiche, tattiche e culturali.
Forte organizzazione difensiva: in tutte e quattro le squadre è stata fondamentale la solidità difensiva:
1934 e 1938: Italia catenacciara ante litteram, con difesa ruvida e compatta
1982: grande equilibrio difensivo con Zoff, Gentile, Scirea, Collovati e Cabrini
2006: una delle migliori difese della storia del Mondiale
Costante è stata la difesa come base del successo; non a caso, l’Italia del calcio da sempre è riconosciuta come la patria della difesa e contropiede. Le 4 nazionali analizzate erano propense ad aspettare gli avversari fino poco oltre la loro metà campo per poi iniziare il pressing.
Giocatori simbolo dalla forte personalità: ogni squadra aveva dei leader carismatici, spesso in cerca di riscatto
1934: Meazza, come già visto prima, l’icona del calcio italiano dell’epoca
1938: Meazza a cui si unì Piola
1982: Scirea, Zoff e poi Rossi che tornato dopo la squalifica per calcioscommesse, divenne l’eroe del Mondiale
2006: Cannavaro e Buffon su tutti
Contesto nazionale difficile: le vittorie sono arrivate sempre in momenti turbolenti per il Paese o per il calcio italiano
Nel 1934 e 1938 in Italia si viveva il contesto fascista, che portava forte pressione politica anche a livello sportivo
1982: c’era da poco stato lo scandalo del Totonero (scommesse) e molti giocatori, tra cui la convocazione di Pablito, furono criticati.
2006: pochi giorni prima del Mondiale ci fu l’esplosione del caso Calciopoli, che coinvolse la Serie A e di conseguenza molti giocatori della nazionale italiana. Paradossalmente, la crisi unì il gruppo e rafforzando lo spirito di nazionale e di squadra.
Allenatori pragmatici: tutti i CT erano più pratici che mediatici
Pozzo: grande stratega e comunicatore, ma riservato
Bearzot: silenzioso, fedele al gruppo, odiava le polemiche
Lippi: molto tattico, uomo di squadra più che showman
Gruppo solido più che stelle isolate: pur avendo giocatori di alto livello, soprattutto nell’82 e nell’06, prevalse il gioco collettivo
Le squadre vincenti erano compatte, unite e resilienti, con sacrificio da parte di tutti
Anche le “riserve” furono importanti
Partenza lenta: in tutte e quattro l’edizioni, la nazionale azzurra non ha brillato all’inizio, ma ha trovato la forma e la sicurezza nel corso del torneo.
1934 e 1938: erano partite sin da subito a eliminazione diretta e comunque durante il torneo si videro progressi evidenti partita dopo partita
1982 nel girone iniziale ci furono tre pareggi: per quello finimmo, nel girone a tre con Brasile e Argentina
2006: passamo bene il girone ma senza dominare
Bisogna anche precisare che le 4 vittorie della Coppa del Mondo sono avvenute in epoche diverse, in cui vi erano alcune differenze:
La prima era quella riguardante le sostituzioni; nel 1934 e 1938 non esistevano le durante la partita; nell’82 ne erano concesse solo 2, con 5 uomini in panchina, mentre nel 2006 le sostituzioni erano 3 con tutti gli altri giocatori (12) disponibili a entrare. Bearzot e Lippi interpretarono in modo diverse le sostituzioni: il tecnico friulano non era un amante del turnover e giocavano sempre gli stessi, salvo infortuni, mentre il tecnico viareggino, soprattutto in alcuni centrocampisti e negli attaccanti lo sfruttò per coinvolgere tutti e per, come accennato prima, dosare le energie.
La seconda differenza era che nel 1934, 1938 e 1982 il portiere poteva prendere la palla con le mani dopo retropassaggio, mentre nel 2006 no, questo ovviamente portava ad una diversa interpretazione della fase difensiva.
In conclusione, possiamo dire che le nazionali Campioni del Mondo avevano un DNA in comune, composto da:
Difesa solida
Forte leadership
Resilienza
Spirito di gruppo
Allenatori pragmatici
Capacità di migliorare in corso
Questi elementi sembrano tratti distintivi del modo di italiano di vincere: non necessariamente bello, ma efficace, combattivo e resistente.
Vi lascio con le immagini dei nostri trionfi, sperando che tutti noi possiamo rivivere presto quelle emozioni.




Commenti